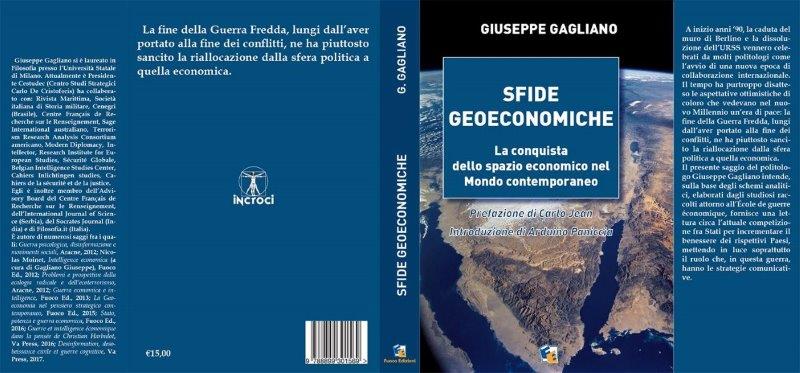Il testo “Sfide Geoeconomiche, La conquista dello spazio economico nel Mondo contemporaneo” di Giuseppe Gagliano rappresenta un percorso storico e politico all’interno dei concetti classici di geopolitica e di strategia, dandogli un’accezione moderna e legata indissolubilmente all’economia nazionale. La Guerra economica, come intesa dai principali esperti della materia, non consiste solo nella volontà nazionale di conquistare i mercati stranieri, ma anche in quella di controllare l’insieme delle risorse e delle materie prime indispensabili al funzionamento dell’economia nazionale. La guerra economica non è un prodotto recente, affonda le sue radici nel secondo dopoguerra ed è emersa con fatica a causa della necessità delle nazioni uscenti dal conflitto di creare strumenti di cooperazione – in particolare in occidente dove la compressione del mondo in due blocchi ha costretto lungamente gli stati ad una solidarietà artificiosa.
I principali autori della riscoperta del concetto di guerra economica sono, tra tutti, Bernard Esambert, Christian Harbulot, George Friedman e Edward Luttwak. Il primo pubblicò il primo saggio sulla guerra economica nel 1991, stesso anno in cui Friedman pubblicò “La futura guerra con il Giappone”. Il contributo di Edward Luttwak è fondamentale, in quanto nel 1990 coniò il termine geoeconomia proprio per designare la riallocazione delle strategie di potere e per anticipare la realtà dei conflitti economici. In Francia sono stati Harbulot e Piclot-Duclos che, con l’École de Guerre Économique”, hanno finalmente reso popolare il concetto di guerra economica applicata alla Francia.
La cultura politica del destino manifesto americano, unita alla schiacciante vittoria della seconda guerra mondiale e, in seguito, all’implementazione in tutto il mondo occidentale del modello economico politico e sociale statunitense hanno condotto, dopo la caduta dell’Unione Sovietica, al ventennio della cosiddetta “iperpotenza” americana. Attraverso l’impareggiabile soft power gli Stati Uniti monopolizzarono il mercato mondiale senza dover fronteggiare alcun rivale per almeno un ventennio. Il neoliberismo e l’idea che lo stato rappresentasse un ostacolo allo sviluppo della globalizzazione finanziaria hanno condotto alla crisi economica del 2007/2008, che si è diffusa in tutto il mondo e ha costretto le nazioni ad entrare in un circolo vizioso di competizione economica tra stati basata sulla concorrenza spietata. Il risultato di questa tendenza che si è accompagnata alla grave crisi del terrorismo internazionale, è stato quello di riportare gli stati a ricoprire il ruolo centrale che l’iper-liberismo economico aveva per anni giudicato malsano. Gli Stati Uniti, seppur mantenendo un’economia liberista, hanno privilegiato da lì in poi i propri interessi nazionali, cosi come hanno iniziato a fare gli attori che si propongono come concorrenti – Cina e Russia in primis.
L’indebolimento del valore delle organizzazioni internazionali deriva propria dalla riscoperta degli interessi nazionali, in particolare i simboli più celebri della “vittoria” dell’economia globalizzata, ovvero le multinazionali e lo stesso World Wide Web, sono in realtà quasi completamente monopolizzati dalla componente statunitense, sicché tutto il mondo si è in realtà illuso di padroneggiare informazione e mercati quando, in realtà, l’iperpotenza non ha mai smesso di direzionare in modo strategico determinati strumenti. Il caso dell’Unione Europea è un emblematico esempio della crisi del concetto di sopranazionalità applicato all’economia: la Germania e la Francia non si rapportano agli altri paesi con la parità ideologica che dovrebbe contraddistinguere l’organizzazione, anzi sembra si siano equamene spartite il ruolo di leader economico e politico non lasciando spazio ad un ruolo di simile importanza per la Gran Bretagna. Quest’ultima, infatti, con la Brexit sta riprendendo in mano quel poco di sovranità nazionale che aveva “concesso” ad un progetto contraddittorio quale l’Unione Europea. L’idea quindi di guerra economica, portata avanti dalle nazioni nel pieno dell’interesse nazionale, si affianca del tutto all’idea di guerra convenzionale, nella consapevolezza che ai giorni nostri esse si identificano come due facce della stessa medaglia.
La discussa crisi del multilateralismo e della globalizzazione, due strutture che hanno funzionato a lungo grazie alla superiorità economica, militare e tecnologica statunitense che aveva l’incarico di proteggerli, si è attenuata grazie al fenomeno del disimpegno del colosso. La nuova amministrazione Trump si è proposta sin dal principio come una valida alternativa sovranista dominata da protezionismo e mercantilismo. Questa volontà di difendere gli interessi nazionali nell’era della comunicazione digitale ha creato una vera e propria intelligence economica fatta di guerra d’informazione e spionaggio che andrebbe analizzata con più attenzione nel nostro paese. In particolare la competizione economica che sta gradualmente aumentando in chiave nazionalistica, sta assumendo, per utilizzare la definizione di Edward Luttwak, la logica del conflitto armato attraverso le metodologie del commercio.
Christian Harbulot, stratega economico e direttore della “’École de Guerre Économique” e Jean Pichot˗Duclos ideatore dell’agenzia di intelligence economica Intelco e principale fautore della EGE, sono le figure più importanti che caratterizzano la nascita e l’evoluzione del concetto di guerra economica in Francia. Alla fine degli anni novanta, infatti, Parigi si trova di fronte ad una crisi politica e morale che la priva di prospettive. Relegata a ruolo di media potenza senza un leader capace di impedirne il declino sulla scena internazionale e rassegnata ad una condizione di vassallaggio, essa perde lentamente il ruolo strategico che da sempre l’aveva contraddistinta. Harbulot e Pichot-Duclos, invece, percepiscono la necessità di ribadire l’esigenza francese di poter contare su una strategia propria in qualità di potenza nucleare e di storico pilastro del sistema internazionale. La riscoperta dell’identità nazionale in chiave economica che l’idealizzazione del capitalismo aveva opacizzato, è un fenomeno che, secondo l’esperto analista ed economista Edward Luttwak, si è lentamente verificato già dall’ultimo decennio del vecchio millennio. Riscoprire gli interessi nazionali significa, dunque, difenderli dagli attacchi esterni, dunque spolverare l’idea di guerra convenzionale abbandonata da decenni per applicarne le logiche all’economia. La guerra economica tocca principalmente il commercio e i mercati, ma abbraccia anche altri attori del modello economico, ad esempio le industrie o i sindacati. In particolare la Francia soffre ancora il peso delle ideologie sindacali: a differenza dei sindacati tedeschi, infatti, quelli francesi si pongono ancora con atteggiamenti ostili di fronte ai padroni delle industrie vanificando numerose trattative nonostante il dichiarato beneficio che, cooperando, apporterebbero alla nazione.
Malgrado la maggiore affezione rispetto ai francesi verso il liberismo puro, gli Stati Uniti di Clinton hanno adottato alcune misure per mantenere il predominio nel mercato globale e si sono preparati alla guerra economica con riforme necessarie ad affrontare in maniera adeguata il crescente peso economico asiatico ed europeo. La prima riforma voluta da Clinton fu la creazione di un organismo, ovvero il Consiglio Economico Nazionale, che aveva il compito di fornire al governo informazioni strategiche. Il leader statunitense, inoltre, oltre a promuovere nuovi mercati, interveniva direttamente in alcune trattative quando la bilancia sembrava pendere dalla parte dei concorrenti. Ad oggi negli USA i rapporti tra Stato e Imprese sono mediati da svariati organismi, il più importante dei quali è l’Advocacy Center, che ha il compito di garantire che le imprese conservino una posizione dominante laddove sia in gioco l’interesse economico nazionale. Nonostante l’evidente tendenza americana a privilegiare le esigenze del proprio mercato, il mondo continua ad assistere ad eventi e iniziative di celebrazione del modello di mondializzazione americana basando tale idolatria su una ipocrisia di fondo, ovvero presentare tale modello erroneamente come funzionale per tutto il resto del mondo, e allo stesso tempo non considerandone le numerose contraddizioni interne. Un sistema del genere potrebbe funzionare soltanto se, come durante la guerra fredda, si riuscisse ad individuare un nemico comune a tutto l’occidente. A questo gli Stati Uniti hanno iniziato a lavorare da decenni, con la teoria dell’Iperoccidente di Ralph Peters, consigliere del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito americano negli anni novanta, o quella di Robert Steele circa la natura transnazionale dei nuovi nemici dell’occidente. A tal proposito le visioni contrastanti di Hutington e Brzezinski rappresentano l’emblema della questione sopracitata. Il primo, nel libro Scontro di Civiltà afferma che blocchi di culture diverse si scontreranno inevitabilmente e consiglia agli Stati Uniti di prendere le redini del blocco occidentale in sua difesa, il secondo, nel testo The Grand Chessboard spiega che gli Stati Uniti a lungo andare non avranno più interesse a preservare il pluralismo continentale.
Studi come questi hanno influenzato le decisioni dell’elite politica ed economica americana che nel corso dei decenni hanno affinato i loro metodi di conquista facendo sì che gli alleati geoeconomici fossero innanzi tutto alleati geopolitici. Attraverso il controllo della maggior parte dei veicoli di informazione durante gli ultimi decenni, la tecnica di accerchiamento culturale ha permesso agli Stati Uniti di mantenere una imponente predominanza anche senza l’uso dell’HardPower. Durante le numerose operazione di Peacekeeping degli ultimi due decenni, Washington ha mobilitato interi dipartimenti per informarsi su quanto stesse accadendo nel paese e sui progetti di ricostruzione, andando a creare solidi legami con i giovani e con le future classi dirigenti. La Francia, emblema dell’alleato geopolitico statunitense che non riesce a svincolarsi da una posizione di sudditanza, non è riuscita a influenzare le aree di crisi in maniera così penetrante, commettendo il grave errore di privilegiare costantemente l’azione diplomatica ai danni della forza d’influenza. Anche all’interno del vecchio continente Parigi ha agito eccessivamente a livello diplomatico, chinando il capo di fronte all’azione esterna degli Stati Uniti, nonostante negli anni sessanta la politica della terza via di De Gaulle l’avesse resa un possibile ponte tra blocco orientale e blocco occidentale. Durante la caduta sovietica, inoltre, le nuove democrazie dell’est hanno avuto necessità di cooperare a livello di intelligence e industrie con gli stati dell’ovest, un’occasione che l’Intelligence tedesca ha saputo sfruttare a differenza dei francesi.
In generale, Stati Uniti e Germania considerano l’intelligence fondamentale nell’elaborazione della loro strategia economica. Nonostante lo storico disprezzo francese verso l’intelligence condiviso da figure come De Gaulle, Pompidou e Mitterand, negli anni novanta la nascita di Intelco ha dato il via ad una esperienza positiva per l’Intelligence francese. Nata come costola del Consiglio di Difesa Nazionale, Intelco ha contribuito ad ampliare il dibattito nazionale sull’intelligence economica e l’information warfare. L’intelco ha risposto all’esigenza di formare una letteratura francese che trattasse di Intelligence economica, industriale e legata alle imprese, e ha contemporaneamente contribuito alla creazione della Scuola di Guerra economica.
L’obiettivo della Scuola di Guerra economica è quello di far sì che la Francia sappia come adottare gli strumenti necessari per proteggere le imprese dalle tecniche di accerchiamento del mercato usate dalla concorrenza. Anche restituire alla lingua francese il rango di lingua economica internazionale e rendere l’area francofona una comunità di affari rafforzata sono obiettivi di primo piano della Scuola. La tendenza è quella di voler ripristinare una politica economica ed una politica estera che non rifiutino totalmente la mondializzazione, ma che tengano conto dei benefici scientifici ed economici della stessa pur agendo per conto degli interessi nazionali. Per fare questo occorre rivalutare l’Intelligence economica, attuando politiche di controllo dell’informazione e spingendo le imprese a proteggersi dagli attacchi cyber. Il fattore umano è decisivo, la Francia conta un enorme capitale umano all’estero specializzato in tech e cyber che, invece, si sarebbe dovuto arruolare all’interno dei confini per proteggere gli interessi della nazione. Nel 1995 venne creato il Comitato per la Competitività e la Sicurezza economica, nonostante il volere del Primo Ministro fosse, allora, quello di coordinare i vari soggetti economici per stabilire nuove politiche condivise in materia di sicurezza economica, progetto che fallì per motivi logistici e legati alla leadership del comitato. Questi tentativi dovrebbero coadiuvare la volontà francese di mettere in discussione l’egemonia americana, proprio come a suo tempo fecero India e Cina.
lain Peyrefitte e Francois de Closets individuarono nel peso e nell’arroganza della pubblica amministrazione il principale ostacolo che stava impedendo alla Francia di adattarsi alla nuova realtà della mondializzazione. Alla Francia manca una capacità di cambiamento priva di traumi per la società, e soprattutto una dottrina che fornisca gli strumenti necessari per creare un’economia che permetta di difendere gli interessi della nazione. La crisi nel nazionalismo francese non si evidenzia soltanto nell’incapacità di adattarsi al mercato globale ma anche dalla disaffezione della popolazione verso la politica. Oltre a questo, anche il settore dell’informazione non sembra aver risposto con efficacia alla realtà economica mondiale che ad oggi, per proteggere gli interessi nazionali, necessita senza ombra di dubbio di risposte adeguate e strategie di conquista basate sulla condivisione delle informazioni. È necessario, infatti, che attori differenti parte di un medesimo sistema-paese portino avanti strategie geo-economiche offensive combinando gli interessi privati con quelli nazionali. La collaborazione collettiva, soprattutto quando si tratta di condivisione di informazioni, è ancora ai primordi nel territorio francese, dove l’individualismo tende ancora a farla da padrone. La Francia dovrebbe, dunque, non solo rifiutare il ruolo di partner passivo, ma anche evitare, in nome di questa diversificazione, di concentrarsi esclusivamente sui progetti dell’Europa sociale, poiché gli stessi hanno dimostrato di non rispondere con efficacia alla macchina della mondializzazione manovrata dagli Stati Uniti.
Il termine Guerra economica, ovvero l’idea che la guerra convenzionale si esprima ai nostri giorni attraverso gli strumenti economici, viene attribuito al generale tedesco Erich Ludendorff, durante la Grande Guerra. Il senso che diamo noi oggi al termine deriva, però, dall’accezione datagli dall’ex Consigliere del Presidente francese Georges Pompidou, Bernard Esambert. La sua opera, “La guerra economica mondiale” sottolinea l’importanza del ruolo di prodotti e servizi che attraverso l’esportazione, vengono utilizzati ai tempi odierni come le migliori armi delle nazioni. Venendo a mancare il nemico comune, nazioni dell’est e dell’ovest depongono le armi iniziando a convergere verso una globalizzazione economica e finanziaria all’interno del quale è l’accaparramento delle risorse e dei mercati l’unica via per rendersi interlocutori credibili e partner strategici. Il contesto degli anni novanta, nel quale è cresciuto notevolmente lo scambio di informazioni e la concorrenza si è fatta spietata, nuovi attori rimasti nell’ombra durante la prima parte del Novecento si sono fatti strada partendo da outsider della globalizzazione finanziaria e concretizzandosi ad oggi come fondamentali per l’economia globale. Paesi come Brasile, Russia, India e Cina, alcuni dei quali dichiaratamente non allineati nel corso della guerra fredda, vogliono prendere parte alla spartizione mondiale delle ricchezze ed entrare a far parte del club dei paesi che “contano”. Nazioni del Sud-Est asiatico e del Sud America che mai avrebbero sperato di essere prese in considerazione come potenze, beneficiano oggi del mutamento del concetto stesso di potenza, che è passato dall’avere un’accezione militare in termini di Hard Power, al Softpower dell’economia, delle risorse, delle tecnologie e delle informazioni. La ricerca di una sempre maggiore potenza politica (che deriva dal semplice assunto che le entità statali, cosi come gli esseri umani all’interno di una comunità, cercano comunque di massimizzare il proprio beneficio), storicamente legata a doppio filo con il concetto di potenza militare, ad oggi si identifica con il potere economico (occupazione, importanza del settore terziario, un minore numero di delocalizzazioni…).
Fondamentale anche la conquista dei mercati e delle materie prime, risorse limitate come le fonti di energia, infatti, fronteggiano domande molto alte e l’approvvigionamento sicuro e continuo è l’unica garanzia per il mantenimento e la crescita del livello economico del paese. L’autosufficienza energetica, ad esempio, risulta fondamentale in un mondo di nazioni che aspirano ad essere indipendenti dalle grandi potenze. Il settore degli idrocarburi (gas e petrolio) rappresenta il massimo esempio di come il possesso di materie prima spinga le nazioni ad entrare in conflitto le une con le altre, e viceversa. L’appoggio delle nazioni occidentali ad Israele durante la guerra del Kippur fece sì che i paesi dell’OPEC (l’organizzazione dei paesi esportatori di petrolio), imposero massicci aumenti sul prezzo del greggio per difendere le ragioni della Siria e dell’Egitto. Numerosi altri metalli e minerali generano tensione tra le grandi potenze a causa della scarsa disponibilità degli stessi e del consistente impiego nell’ambito dell’industria pesante e militare (si pensi, ad esempio, al Titanio).
Un’altra risorsa di cui ad oggi ogni nazione che aspira ad essere competitiva non può fare a meno è la conoscenza tecnologica. Accaparrarsi le risorse e sviluppare un Know-how tecnologico sono i due obiettivi principali degli stati che vogliono accrescere il proprio potere contrattuale anche nei confronti delle grandi potenze. In generale il concetto di tecnologia sviluppata è legato a doppio filo con quello di potenza, in quanto le prime sono state storicamente impiegate con larga priorità sulle armi, dunque in guerra. La potenza di uno stato è inevitabilmente frutto delle proprie capacità tecnologiche, non di meno nel secolo appena trascorso, dove abbiamo assistito all’apparizione della bomba nucleare, il centro gravitazionale dei rapporti di forza che hanno segnato la storia dell’umanità. La corsa tecnologica presenta una serie di svantaggi: si può sempre essere raggiunti, di conseguenza lo sforzo di rinnovamento deve essere costante, la ricerca iniziale non sempre produce una soluzione tecnologica nello stesso paese in cui è cominciata, inoltre, lo sviluppo della tecnologia militare non comporta necessariamente un accrescimento della propria potenza.
insieme a ciò le esportazioni hanno acquisito un valore fondamentale nella misura in cui esprimono il valore e la potenza di una nazione. L’accrescimento del ruolo di protagonista degli stati sovrani negli scambi internazionali e la nuova tendenza mercantilista sta, in sostanza, screditando l’idea che la globalizzazione stia indebolendo gli stessi. Ancora una volta Luttwak suggerisce un’interpretazione al dogma della guerra economica suggerendo ai burocrati delle maggiori potenze occidentali che diplomazia e conflitto tra nazioni siano state sostituite dalla geo-economia nella sua accezione così contrastante con l’idea di economia globalizzata. I protagonisti degli scontri geo-economici sono chiaramente le nazioni: Stati Uniti e Giappone sono i paesi d’origine della mole più imponente di multinazionali, le altre nazioni le seguono con uno scarto imponente, ma allo stesso tempo i mercati emergenti (BRICS, Corea del Sud, Taiwan) evidenziano un tasso di crescita nettamente superiore che potrebbe rovesciare la classifica nei prossimi anni. Un altro attore fondamentale in questa “guerra” sono le imprese, considerate come le truppe al fronte che devono partecipare al conflitto tra le nazioni. La potenza di queste truppe, ovvero le multinazionali, è data dalla capacità di esportare e di conquistare il mercato estero, abilità misurata dall’indice di transnazionalità di un’azienda. Chiaramente, anche se i capitali delle aziende sono per la maggior parte detenuti da residenti stranieri, ci sono dei criteri per attribuire ad un’azienda una nazionalità e un’identità all’interno del conflitto economico: il territorio dove la società è stata fondata, le norme/ rapporti istituzionali dipendenti dal paese in cui essa ha sede, e infine, l’ubicazione del centro decisionale, che potrebbe coincidere con la nazionalità del fondatore.
A livello geostrategico, nel il sistema bipolare nel quale due avversari si sono contesi il mondo ampliando le proprie sfere di influenza, gli attori si sono moltiplicati creando nuovi spazi di potenza dove inserirsi. Il terzo mondo, i paesi in via di sviluppo, e soprattutto le potenze emergenti (BRICS al primo posto) hanno acquisito un’importanza settoriale mettendo in crisi l’idea del multilateralismo classico. Anche il concetto stesso di rivalità si è ribaltato: nazioni rivali in ambito regionale possono essere costrette a cooperare per fronteggiare un terzo attore che si accinge ad appropriarsi delle risorse della regione. Quali sono le armi che gli stati utilizzano per perpetrare questo conflitto di matrice economica? In primo luogo le armi di tipo indiretto, quelle che agiscono nelle retrovie: formazione, sviluppo, ricerca. La competitività delle aziende attratte da politiche fiscali leggere è un’arma indiretta che fa aumentare il potere di mercato delle nazioni. Un’altra arma, appunto, indiretta, sfruttata nella guerra economica è l’intelligence. Decifrare le intenzioni dei concorrenti per anticiparli e allo stesso tempo, sapersi confrontare con la sicurezza delle proprie informazioni è fondamentale per attuare una strategia geoeconomica a livello di sistema paese. Le nostre economie e le nostre società, essendo fortemente digitalizzate, presentano rilevanti vulnerabilità, tra cui proprio quella di far parte di un sistema iper-connesso. A causa della fragilità digitale di grandi multinazionali, aziende o anche delle infrastrutture critiche, le nazioni hanno iniziato a formalizzare il proprio impegno nell’ambito dell’Intelligence informativa. Nel mondo di oggi, insomma, le campagne di disinformazione non sono più legate esclusivamente all’intelligence nazionale, bensì anche e soprattutto all’intelligence interna alle aziende. Esempi di armi offensive a disposizione degli stati sono, ad esempio, il boicottaggio, le sanzioni, il contingentamento delle importazioni e i dazi doganali quando particolarmente significativi. In generale questa sorta di nuovo protezionismo si manifesta con manovre particolari, che agiscono nell’ombra mentre su un piano pubblico si continua a veicolare l’idea di un mercato globale e di una cooperazione a livello commerciale del tutto positive.
Quando si afferma il principio di guerra economica non si può tralasciare il concetto di patriottismo economico, di cui si ricorda una delle prime enunciazioni tra gli anni novanta e i primi del duemila, in particolare grazie al contributo del deputato francese Bernard Carayon e dell’ex primo ministro de Villepin. Entrambi sostenevano l’importanza di individuare interessi comuni fra stato e settore privato al fine di dare una connotazione più patriottica all’intera economia nazionale. Negli Stati Uniti uno degli strumenti difensivi in ambito di guerra economica più utilizzato è il consumo patriottico, ovvero l’idea di privilegiare l’acquisto di prodotti nazionali. Esso fornisce una difesa efficace contro gli attacchi della guerra economica: possiamo trovarne un primo esempio nel Buy American Act del 1933 – una delle misure volte a risollevare il paese dopo la crisi del ’29 – fino ad arrivare al presente con l’ordine esecutivo “Buy American, Hire American” di Donald Trump (per non citare la questione, ancora più attuale, dei dazi americani sul settore siderurgico). In sintesi, gli auspici dei grandi pensatori dell’Ottocento circa uno scenario di pace e cooperazione globale trainato dall’utopia del liberismo puro e del commercio globalizzato non si sono realizzati completamente, bensì solo in parte, e allo stesso tempo stanno lentamente causando il rifiuto del Globalismo in nome di un rinnovato Sovranismo.
Il motivo per cui tra questi due leader, i cui governi sono distanziati da quasi un secolo, la nozione di guerra economica è stata relegata ai margini delle teorie geostrategiche è che il protezionismo e i nazionalismi degli anni trenta e quaranta avevano quasi distrutto l’Europa. Dopo la fine della seconda guerra mondiale non solo Europa, ma anche gli Stati Uniti e la Russia hanno sentito il bisogno di connettere le compagini nazionali più vicine sulla base di ideologie comuni, il liberismo in primo luogo, ma anche l’identità europea, la lotta contro il blocco contrapposto (NATO e Patto di Varsavia), un diritto internazionale condiviso e la cooperazione finalizzata a creare una grande sfera di influenza “occidentale” non colonizzatrice ma esportatrice di pace benessere. Le idee di Montesquieu come di altri filosofi dell’epoca, nel quale il commercio veniva rappresentato come un veicolo di pacificazione tra i popoli, che ne rafforza i legami generando benessere, hanno contribuito al rafforzamento dell’economia globale nel secolo successivo. La crisi della dottrina liberista è esplosa nei primi del duemila, con la crisi e l’ascesa del protezionismo.
Secondo quanto scritto da Christian Harbulot, la guerra economica non si verifica in parallelo ad una guerra convenzionale, anzi la prima si riscontra sempre in tempo di pace, in quanto l’accrescimento di un paese sembra essere una priorità solo quando non c’è un nemico da abbattere. Un’altra differenza si trova nel concetto di impresa, un attore rilevante tanto quanto gli stati-nazione. Secondo quanto affermato dall’autore, infatti, la guerra economica è più simile alla guerriglia, in quanto le operazioni privilegiate sono segrete, le armi favorite sono quelle della manipolazione e della demoralizzazione dell’avversario, e gli attori in campo non combattono con armi convenzionali ed eserciti schierati, bensì con intelligence e attacchi mirati.
Disinformazione, propaganda e sovversione sono strumenti che hanno acquisito una centralità anche nelle aziende e nel settore privato, come dimostrano riflessioni come quelle di Philippe Baumard, Loup Francart, François Géré, Charles Prats e Christian Harbulot. Il Generale Loup Francart concepisce la disinformazione, espressione relativa alle azioni dell’intelligence russa durante la guerra fredda, come una generica propagazione di informazioni menzognere. La manipolazione delle informazioni allo scopo di influenzare il giudizio dell’attore al quale si rivolge è dunque applicabile facilmente al contesto della società civile e dunque anche delle aziende private. Anche la propaganda, che a differenza della disinformazione veicola un’ideologia sottolineandone la superiorità rispetto alle altre visioni del mondo, è un’arma delle più incisive nella guerra economica. Come atto manipolatorio, infatti, agisce a livello privato attraverso la padronanza della produzione di conoscenza: non a caso le strategie industriali puntano sulla produzione di notizie per anticipare i concorrenti e l’evoluzione dei mercati nel prossimo futuro. La gestione strategica della notizia economica diventa così una delle attività fondamentali delle imprese che vogliono agire a livello globale. A livello pratico il modo più efficace per agire in tal senso è applicare alla competizione tra le imprese la stessa logica dell’arte della guerra di Sun Tzu, o quella certamente più recente e meno soggetta alle interpretazioni del piano Jael di Winston Churchill. Egli infatti orchestrò una vera e propria guerra d’informazione contro la Germania Nazista, non ultimo ingannando il nemico circa i luoghi di sbarco. La strategia di sovversione cosi come descritta da Roger Mucchielli, mira ad indebolire il potere degli avversari minando le fondamenta stesse delle sue difese naturali. Secondo l’analista francese, le azioni sovversive devono mirare a disintegrare i gruppi instillando il dubbio sui valori da distruggere, screditare le autorità e i suoi difensori e indebolire tutti i gruppi che possono rappresentare delle unità di soccorso dell’ordine stabilito. La manipolazione della conoscenza, applicata mettendo ad esempio in crisi un attore concorrente su una questione prettamente morale andando a suscitare lo scalpore dell’opinione pubblica è un’arma utilizzata parallelamente da stati ed imprese. Alcuni dibattiti come quelli sul nazionalismo economico sono viziati da un contesto globalizzato del tutto ipocrita, all’interno del quale i rapporti di forza a livello informativo pendono per i più potenti (a livello globale gli Stati Uniti). I più deboli, sia se si parla di realtà private che di questioni politico/pubbliche, hanno imparato a sconfinare nell’illegalità. Si pensi, ad esempio, alle campagne di protesta degli ambientalisti contro le grandi multinazionali, o al terrorismo (non necessariamente islamico) utilizzato come mezzo per rivendicare diritti attraverso l’esaltazione massima del sacrificio umano e la violenza indiscriminata.
In questa ottica diventa facile utilizzare le categorie di buoni e cattivi per rappresentare, da un lato, gli esponenti della società civile, e dall’altro, i “potenti”. In una prima fase storica i gruppi in seno alla società civile si esprimevano attraverso la protesta, sottolineando la loro debolezza e andando a suscitare l’empatia generale. Ad un certo punto, però, hanno iniziato a ricorrere all’azione eclatante, spesso identificata nell’aggressione (comunicativa sì, ma anche fisica). La verità è che i soggetti comunemente considerati deboli utilizzano strategie forti, così come rivelato dallo studio di Harbulot e Dènècè circa le manipolazioni e l’omertà a cui si sottomettono le ONG all’interno delle potenze straniere nel quale si trovano ad operare.
Contrariamente a quanto si aspettasse la società degli anni passati, l’egemonia dell’informazione non ha rafforzato l’autonomia del suo uso da parte dei cittadini, che a causa della moltiplicazione dei mezzi di comunicazione e delle informazioni presentate, ovviamente, in maniera non univoca, si trovano immersi all’interno di un sistema manipolatorio senza precedenti. Le teorie complottiste nascono, infatti, proprio dalla crescente mole di informazione e controinformazione fornita dalle migliaia di veicoli comunicativi che arrivano a mettere addirittura in discussione i principali avvenimenti storici dell’ultimo secolo. La guerra d’informazione è sempre esistita, ma solo con l’avvento di Internet è diventata un fattore decisivo. La dimostrazione più lampante di questa affermazione si trova nella strategia comunicativa del terrorismo islamico firmato ISIS, un’organizzazione che negli ultimi anni ha utilizzato il cyberspazio in modo impeccabile. Gli Stati Uniti hanno utilizzato internet nella guerra d’informazione contro i propri avversari (statali e non) comprendendone le capacità sin dall’inizio, mentre le ricerche condotte in Francia hanno evidenziato come Parigi abbia mantenuto la peculiarità di un’intelligence difensiva anziché offensiva, non avendo ancora compreso che lo scopo della guerra d’informazione ad oggi è la delegittimazione dell’avversario. L’esempio più lampante di questa guerra è il caso di Israele contro il terrorismo palestinese: Al Fatah, l’organizzazione paramilitare palestinese formatasi nelle scuole del Patto di Varsavia, Hezbollah in Libano e Hamas in tempi più recenti hanno compreso che le perdite civili provocate dal nemico possono essere utilizzate per conquistare l’opinione pubblica mondiale. Durante l’operazione Piombo Fuso, le elites di Hamas avevano progettato le rampe di lancio dei missili lanciati contro Israele nei pressi di scuole ed ospedali, consapevoli del fatto che la risposta Israeliana contro i siti di lancio avrebbe provocato morti tra i civili e che questo, ripreso a 360° da Al Jazeera, avrebbe dato un risalto maggiore alle vittime. Da questa consapevolezza non ne deriva solo un appoggio ideologico, ma anche fondi, fondi che vengono investiti in armamenti, dunque armi per una guerra combattuta in modo atipico.
Secondo la logica della guerra dell’informazione, così come dimostrato da casi esemplari come quello Vietnamita, quando i cittadini americani dopo la diffusione delle immagini riguardanti l’offensiva del Têt, compresero di essere stati “presi in giro” dall’informazione americana circa la vittoria assicurata, la ragione appartiene a chi è più debole e si presenta come vittima. A seguito di quel caso, gli Stati Uniti hanno preso in mano la guerra d’informazione che sembrava voler minare le basi del suo potere, e l’hanno utilizzata per presentarsi come i paladini delle popolazioni oppresse dalle dittature al cui fallimento erano interessati. Le rivoluzioni colorate in Serbia, Georgia, Ucraina e Kirghizistan così come le Primavere Arabe sono il frutto della strategia americana, contro i Russi nel primo caso e contro i detentori delle risorse petrolifere nel secondo. Negli ultimi anni sono esplosi due scandali riguardanti la guerra delle informazioni: Wikileaks e il Caso PRISM di Edward Snowden. Questi casi hanno evidenziato la necessità per i paesi occidentali di concentrarsi sulla dimensione strategica del problema delle informazioni e sulla protezione delle stesse: mantenere la sovranità nazionale significa, anche, rinunciare ad una parte di privacy in nome della sicurezza. Tutto questo andrebbe, essenzialmente, studiato anche da un punto di vista accademico. C’è scarsa attenzione verso le informazioni, e i ricercatori occidentali tendono a concentrarsi sui metodi di propaganda attuati nella conduzione dei conflitti militari, tralasciando il dato incontrovertibile che la guerra d’informazione è continua nel tempo e sempre più pervasiva.
La guerra dell’informazione presenta dinamiche varie che ricalcano, in alcuni casi, le classificazioni circa la convenzionalità dei conflitti. La disinformazione ha agito in contesti simmetrici (seconda guerra mondiale, in particolare grazie alle intuizioni di Churchill), dissimmetrici (come nel caso delle guerre di Hezbollah contro Israele) e asimmetrici (in particolare la lotta internazionale contro il terrorismo), definendo la conflittualità connaturata alla società dell’informazione e la strategicità insita nella stessa. È fondamentale ribadire, però, che la guerra d’informazione si combatte maggiormente in tempo di pace. Il fatto che le imprese subiscano centinaia di attacchi di questo genere viene spesso opacizzato dalla limitata percezione della rilevanza delle informazioni.
Negli Stati Uniti strutture come i think thank hanno in mano un forte potere informativo. Il National Endowment for Democracy (NED) si è presentata sin dagli anni ottanta come una fondazione privata senza scopo di lucro a servizio della promozione di libertà e diritti, mentre è stata per decenni uno strumento d’influenza di prim’ordine che ha finanziato in maniera più o meno occulta gruppi di ribelli in tutto il mondo. Grazie a organizzazioni come la NED gli Stati Uniti hanno fatto i propri interessi economici e geopolitici diffondendo attraverso le cellule ribelli l’idea che i principi di democrazia e libertà dovessero essere insegnati e successivamente esportati anche, purtroppo, con risvolti tutt’altro che non violenti. Le primavere arabe, ad esempio, hanno certamente avuto un’impronta democratica e laica ma sono sfociate nella nascita e nel progredire di un fondamentalismo islamico che ha attecchito, contrariamente ad ogni aspettativa, sugli strati più poveri delle popolazioni locali. Chiaramente alla base delle rivolte arabe vi sono cause endogene di natura politica, economica e sociale. Da un punto di vista politico le divisioni in seno al mondo arabo e la mancanza di governi democratici e stati solidi ha contribuito allo scatenarsi delle proteste. L’onnipotenza dei dittatori, la lentezza della burocrazia, la non intenzione di adeguarsi agli standard di rispetto delle libertà fondamentali e i modelli di sviluppo obsoleti che hanno causato la povertà e l’arretratezza delle classi meno abbienti hanno, insieme ad un leggero aumento dell’alfabetizzazione, causato rivolte violente facilmente assimilabili alla rivoluzione francese. Oltre alle cause endogene hanno contribuito in via del tutto esogena interventi ed azioni d’informazione da parte di paese non coinvolti, associazioni militanti, fondazioni e ONG. Le rivolte, in sostanza, sono state letteralmente istigate da azioni di propaganda e manipolazioni mediatiche, molte delle quali hanno raccolto tragedie come quella di Mohammed Bouazizi in Tunisia o Khaled Said in Egitto manipolandone alcuni aspetti e diffondendole come il simbolo della sofferenza delle popolazioni locali. La sforzo economico statunitense (attraverso strumenti come USAID) per sostenere le forze ribelli in Egitto e Tunisia è stato rivelato aggirarsi attorno ai 66.5 milioni di dollari nel 2008 e 75 milioni nel 2009. Un finanziamento del genere veicolato attraverso ONG e media locali e occidentali ha fatto sì che l’opinione pubblica credesse ciecamente alla versione statunitense dei fatti, frutto in parte di una distorsione della realtà.
Un ulteriore veicolo fondamentale per comprendere le ragioni della protesta tunisina è Al Jazeera. Mezzo d’informazione a sostegno della lega araba, negli anni si è assunta il ruolo di difensore delle correnti islamiche più ribelli e lontane dalle dittature nazionalistiche. Considerato uno strumento sovversivo, Al Jazeera non ha solo alimentato le proteste tunisine, ne ha anche diffuso le immagini promuovendo azioni non dissimili in Egitto. In sostanza le azioni di guerra d’informazione nel caso delle primavere arabe hanno avuto come risultato la creazione di un nuovo tipo di terrorismo islamico, che impiega non solo la violenza come storicamente dimostrato, ma anche un costante ricatto emotivo manipolato da un’informazione poco analitica e volta solo al sensazionalismo terzomondista.
Il fenomeno ISIS, che trova le sue origini nella guerriglia e nel terrorismo di Al Qaeda dei primi anni del ‘2000, si è differenziato dalle altre organizzazioni terroristiche per l’uso magistrale della guerra d’informazione. Esempi della strategia del Califfato sono: la diffusione dei video delle condanne a morte intrisi di odio religioso e rivendicazioni politico-territoriali, testi di propaganda redatti in lingua inglese per meglio arrivare alle menti dell’occidente, e veri e propri manuali indirizzati a chiunque, nel mondo, volesse partecipare alla loro battaglia (come costruire armi con ciò che si trova comunemente in casa o come preparare un attentato terroristico). La comunicazione ISIS si fonda su una retorica antioccidentale ed è stata coltivata parallelamente sia su un piano di messaggio politico sia sul piano dell’intrattenimento, con l’Al Hayat Medi Center specializzato in produzione di film e video. Gli islamisti dell’ISIS hanno proposto un’immagine di coesione all’interno del califfato dando all’unità sociale una radice quasi nazionale, andando ad intaccare anche i legami possibili con gli stati arabi vicini (oltre ad aver perpetrato violenza sia contro sciiti che contro sunniti). Il sostegno della popolazione, che nel periodo d’oro dell’ISIS ha contato almeno dieci milioni di anime, deriva dall’immagine (puramente strumentale ma mediaticamente imbattibile) di un califfato dell’età d’oro rinato dalle ceneri di un passato glorioso, a sostituzione dei regimi corrotti instaurati dagli americani in Iraq. Un ulteriore obiettivo dell’ISIS è quello di destabilizzare le democrazie occidentali: per fare questo il movimento ha predisposto una strategia di comunicazione esterna fondata su una perfetta padronanza dei messaggi da inviare e delle immagini utili al raggiungimento dei suoi fini.
Secondo la teoria di Eric Denécé le strutture organizzative dei movimenti di contestazione nel mondo stanno assumendo una particolare composizione che si adatta ai nuovi mezzi comunicativi. L’autore fa, a tal proposito, il confronto tra un funzionamento a Ragno, dove c’è un organo centrale che controlla tutta la rete, e quello a Stella di Mare, che presentando gli organi principali presso le estremità tende a non morire qualora spezzata a metà. Al Qaeda, ad esempio, sembra aver tratto ispirazione dal modello Starfish creando gruppi autonomi legati dalla stessa ideologia ma che agiscano autonomamente. Il risultato è che catalizzatori quali ideologia e obiettivo comune riescono a costituire un collante sufficientemente potente da mantenere uniti i gruppi poco centralizzati. Il sistema Starfish, incoraggiando singoli movimenti di lotta e resistenza affidandone ad ognuno la responsabilità e minimizzando i legami con l’ideatore centrale, lascia molto spazio all’intelligenza collettiva. Se i principi vengono applicati con successo di riesce a lavorare insieme anche se non ci si conosce o se non si parla direttamente. Come? Ispirandosi a vicenda, esattamente come agiscono i lupi solitari negli attentati terroristici “ISIS Inspired” contro le principali città europee. Il modello Starfish può essere applicato anche al prototipo della resistenza/lotta non violenta, metodi spesso utilizzati da gruppi di ambientalisti, no global, pacifisti e organizzazioni che promuovo alcuni tipi di diritti. Come descritto da Gene Sharp, l’obiettivo di questo tipo di lotta, analogamente alla guerriglia, è quello di prendere l’avversario di sorpresa, screditarlo, destabilizzarlo, per portarlo in un territorio sconosciuto dove l’unica risposta possibile sembra essere la violenza. Secondo la definizione di Sharp, esistono cinque forme di azione diretta non violenta: la protesta (pressione, comunicazione), la persuasione non violenta, la non collaborazione sociale (sabotaggio, disobbedienza civile), la non collaborazione economica (rifiuto di pagare le tasse, sciopero politico), e, infine, la non collaborazione politica (boicottaggio degli organi legislativi). A queste categorie possiamo aggiungere un nuovo tipo di attivismo: il cyberattivismo. Quest’ultimo utilizza gran parte delle forme di azione diretta ma previene qualsiasi rischio fisico (compreso quello di essere riconosciuti), potendo svolgere attività di sensibilizzazione anche in forma anonima (in particolare per quanto riguarda l’utilizzo del deep web, il quale non permette in alcun modo l’identificazione dell’utilizzatore). Fatte queste premesse possiamo arrivare alla conclusione che nell’epoca in cui stiamo vivendo, informazione e sicurezza viaggiano su binari paralleli: la pirateria informatica, in particolare nella sua applicazione a livello aziendale e nel costante conflitto tra potenze economiche, sta agendo in maniera invasiva sulla diffusione di informazioni sensibili, trasformando la rete – punta di diamante della comunicazione moderna – in uno strumento alla portata di tutti per combattere ogni tipo di guerra.